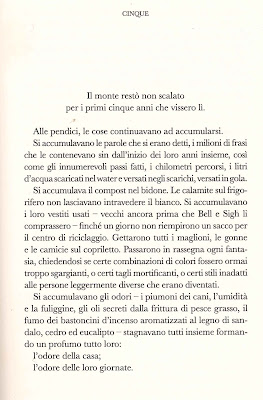[seconda e ultima parte]
La cura, il rispetto sono una sorta di terreno fertile dove Klassen fa crescere i suoi semi preferiti.
Si allude al suo irrefrenabile bisogno di dare sempre e comunque una scossa finale, possibilmente anche un po' inquietante, a un andamento tutto sommato regolare e rassicurante. E ancora una volta gli occhi dicono tanto.
Uno potrebbe illudersi che in libri così l'inquietudine, il piccolo mistero non trovi casa, e invece (effettivamente è costato un lungo confronto con l'editore che alla fine ha ceduto)... Qui in effetti non muore nessuno, ma ci sono personaggi che partono (ma poi ritornano) e altri che arrivano quando fa scuro e poi e stazionano.
Attenzione però, che lui mai dimentica che questi tre libri sono destinati a un pubblico di piccoli piccoli, ragione per cui va a toccare corde sensibili.
E come lo fa? Costruendo per loro scenari, dove piccole storie accadono, dove gli occhi parlano (i lattanti sono i primi a dover imparare quel linguaggio), dove le figure sono forme, dove tutto quello che accade accade nell'arco di un giorno (altro leitmotiv di Klassen) e soprattutto dove tutto appartiene in modo incontrovertibile al lettore stesso.
Questo è per dire del grande salto in avanti - anche emotivo, ma soprattutto di visione - che fa Klassen rispetto a quanto visto finora per i toddlers.
Lui che, fin dal principio della sua carriera, ha sempre cercato la semplicità (al confine della monotonia che fracassava con il crimine finale) ora sembra essere arrivato a un punto interessante.
In questi tre libri manca del tutto il gusto per il problema del personaggio e anche il personaggio, inteso come quello che guida la storia, di fatto non c'è.
Ci sono, al suo posto, una serie di entrate in scena, peraltro rigorosamente mute, da parte di figure che convivono in armonia proprio perché il luogo che vanno a costruire sia il più accogliente possibile. E finisce così: lo scopo dei tre è quello di creare piano piano posti per poi regalarli ai propri lettori. È qui è il salto cui alludevo.
Che bella cosa. Di nuovo.
Your places, non a caso, è il titolo di una mostra che è durata una settimana di febbraio con le illustrazioni di questi tre libri e Jon Klassen, per un intero giorno a firmare le copie che una interminabile fila di adulti che glieli sottoponeva...
La costruzione a livello visuale di questo scenario è di nuovo un elemento pieno di interesse.
Sembra davvero che ci siano mani trasparenti che vanno a disporre in un preciso quanto voluto ordine spaziale (tridimensionale, nonostante il piano del foglio) i singoli personaggi. E poi li mettano in connessione. Complici anche gli occhi di ciascuno di loro.
Funziona così: le "cose" entrano in scena nella pagina di destra - sole escluso - accanto al testo, mentre nella pagina di sinistra la "cosa" precedente ha preso posizione senza più perderla.
Accade quindi che nelle pagine di sinistra lo scenario si va componendo e arricchendo di "cosa" dopo "cosa", il cui ingombro era stato previsto fin dall'inizio. Viene spontaneo ricordare, per quelli che almeno una volta lo hanno fatto, di quando con i bambini piccoli gli montavamo davanti fattorie o stazioni di treni, piccoli mercati, camere da letto per bambolotti... Per poi dare loro, nella disposizione scelta, una informazione successiva, un senso più generale a cui riferirsi per cominciare il gioco vero e proprio.
E se così davvero è, mi parrebbe plausibile pensare che questi libri contengano qualcosa che sta in mezzo tra il gioco puro e la narrazione.
Che cosa bella. Di nuovo.
Adesso occorre tornare alla questione degli occhi e degli sguardi.
Gli occhi e gli sguardi che pagina dopo pagina cambiano sono di nuovo un attestato di stima nei confronti dei lettori, ma anche un modo per suggerirgli, come se ce ne fosse bisogno, che ogni personaggio, anche vegetale o minerale, ha un suo preciso sentire e un suo autonomo moto di reazione a ciò che capita. Uno su tutti lo sguardo delle "cose" già presenti, all'arrivo del falò sull'isola. Be' a quel che so sono i bambini le creature più animiste che conosco. Per loro quegli occhi e quegli sguardi sono solo una conferma, mentre per gli adulti co-lettori rappresentano il non plus ultra della goduria. Come è accaduto dal primo libro di Klassen in poi.
Ancora e ancora una cosa bella.
I libri che già così possono definirsi grandiosi e in qualche modo unici e rivoluzionari nei confronti del canone dei cartonati per bambini piccoli piccoli hanno un'ulteriore lucentezza nei diversi piccoli doni che Klassen lascia appoggiati qui e lì per i suoi lettori. E non mi sto riferendo all'uso ripetuto degli aggettivi possessivi che attestano che cosa sia e di chi sia.
Sono regaletti più nascosti...
Il primo dei quali sta nella qualità del mondo che sta offrendo ai suoi lettori: nella fattoria il cavallo ha il fieno, nella foresta c'è l'acqua e il ponte per attraversarlo, nella foresta c'è anche un fantasma gentile e di parola, e una capanna per ripararsi, nell'isola c'è una tenda da campeggio, un fuoco magico che non si spegne mai e una barchetta per navigare, nella fattoria c'è un fienile dove tanto l'ottimo camion quanto il cavallo satollo potranno trascorrere felici la notte.
E noi con loro!
Buona notte, buona notte.
Carla
Noterella al margine. Due spigolature sul fenomeno editoriale. I tre libri vengono annunciati per il 4 febbraio: si possono prenotare. Poi spariscono dal mirino: l'attesa, preannunciano, potrebbe durare anche mesi, visto il successo immediato i libri sono andati a ruba.
Non si stenta a crederlo, visto cosa sono...
Tu isla, Jon Klassen, Oceano Travesia 2025
Dein Wald, Jon Klassen, Nord-Süd Verlag 2025
Your Farm, Jon Klassen, Candlewick Press 2025