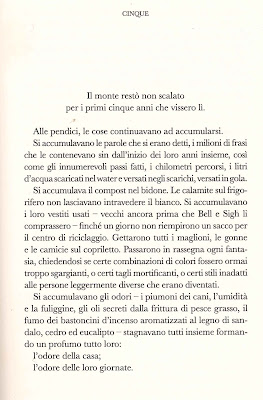"Con un coltellino qualsiasi possiamo tagliare, aprire, dividere, sbucciare, perforare, separare, affilare, radere, incidere, modellare scuoiare, tagliarci (attenzione!) e fare del male (molta attenzione!).
Non bisogna dimenticare che il coltello a serramanico è un'arma.
Per questo molti adulti preferiscono che non sia alla portata dei bambini. Pensano che sia pericoloso. E in effetti può esserlo. Ma se impariamo a usarlo con cautela (senza fare sciocchezze), quante cose ci permette di fare!"
Se non siete d'accordo con quanto esposto nelle righe sovrastanti, questo post e questo libro non fa per voi. Mollate subito e andate a farvi un giro.
In caso diverso, sedetevi perché continuo a non essere breve.
Ricordo distintamente quando, ero madre da poco più di un anno, vidi il figlio di amici di poco meno di tre anni con un cacciavite in mano e, alla mia perplessità se fosse prudente, mi venne risposto: certo, gli abbiamo insegnato come usarlo.
Ecco.
Questo libro va in quella direzione, senza paura. Ragione per la quale la scelta degli oggetti (che poi è il modo migliore per capire il pensiero di chi l'ha scritto) mi pare davvero attenta al pubblico di riferimento, ovvero i bambini curiosi e bellamente ignora i possibili timori di genitori benpensanti.
Senza nessuna censura si parla di come uccidere le mosche e si discute di coltelli.
Ci sono oggetti che fanno parte del loro parco giochi - la palla, il frisbee e forse il dado. Gli altri, che comunque appartengono al loro universo visivo, sono dentro per due ragioni diverse: da una parte è proprio molto interessante e utile capire come funzionano - il volante, il bottone - dall'altra sono così tanto apparentemente semplici da lasciare basiti nell'apprendere quanto in realtà complessi siano, fisica e chimica per capirne di più - il mattone, il liquido, e l'imbuto.
Credo che se un ragazzino (come pure un adulto) finora non abbia dimostrato interesse per come lavora una tazza del gabinetto, vada preso per le orecchie e gli vada spiegato per benino.
Sapere come funzionano le cose è un atto politico.
Prevede, innanzi tutto, concentrazione e osservazione per essere capaci di valutare di quel determinato oggetto l'importanza, il suo valore sociale e tenere sempre a mente lo sforzo che ha richiesto inventarlo, costruirlo, manutenerlo.
Se fossimo più consapevoli di come funziona la spazzatura, non avremmo i cassonetti che abbiamo...
Lo stesso criterio va applicato sempre, o quasi sempre.
Ma questa attitudine è poco praticata: la distrazione, il dare per scontato, il non curarsi e, più in generale, la fretta e la superficialità sono diffuse e remano contro.
Chi ha voglia di soffermare lo sguardo e quindi il pensiero sul cestino del pane, ammesso che sia di giunco e non di plastica a stampo?
Chi si soffermerebbe sul tragitto che si fa fare al filo per attaccare un bottone, se non colui che detto bottone sta attaccando?
Chi si mette a ragionare sul fluire "innato" di un liquido? E sulla sua ferma volontà a non rimanere mai fermo? Leggere per credere: un trattatello di fisica che brilla per chiarezza.
Non a caso nel prologo Gustavo Puerta Leisse sottolineava che "condividere le scoperte nel modo più accattivante possibile" forse è la chiave vincente di questo strano libro.
Piccole pillole di saggezza si colgono qua e là sul significato della parola cosa, sulle onomatopee, sul calcolo delle probabilità, la distinzione, appunto, tra cosa e oggetto (si legga il mattone), tra attrezzo e strumento, il concetto di meccanismo, il concetto di contenitore...
E quindi si arriva al gran finale: l'imbuto, che è anche il nome della casa editrice che i due autori un giorno di qualche anno fa hanno fondato: Ediciones Modernas El Embudo, ma è anche un simbolo!
L'imbuto non è un contenitore, ma un elemento che è necessario al passaggio da un contenitore più grosso a tanti più piccoli. Quindi un imbuto, è un po' come l'uguale in matematica.
L'imbuto ha anche fare con la fisica, con l'arte ed è nascosto dove meno te lo aspetti e anche noi nel nostro corpo ne abbiamo un certo numero...
Mi debbo fermare.
Questo è per dire che se questo libro invece di contenere quattordici diversi oggetti, ne avesse contenuto uno solo, l'imbuto, ripetuto quattordici volte, io lo avrei bevuto come un bicchiere d'acqua quando si ha sete! [fine]
Carla
"Lezioni di cose. Un universo a portata di mano", Gustavo Puerta Leisse, Elena Odriozola (trad. Maura Romeo), Quinto Quarto 2025
"La sicurezza degli oggetti", in Cose spiegate bene, AA.VV. Iperborea 2025
"Toilet How it works" , David Macaulay, Sheila Keenan, Roaring Brook Press 2013
"Dieci splendidi oggetti morti", Massimo Mantellini, Einaudi 2020