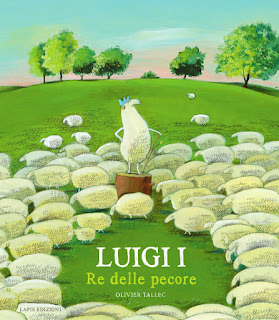Da persona indecisa e poco propensa alla sintesi quale sono, quando mi trovo di fronte a un problema che non offre una immediata soluzione affido le mie valutazioni al tempo. Lo lascio scorrere come si farebbe con un fiume, costruendo a valle le mie domande a forma di diga. Poi, sto seduta lì, paziente, a osservare cosa arriva: suggerimenti, indizi, ripetizioni.
È osservando sparsi sul palmo i pezzetti di ciò che si accumula a ridosso dell’ostacolo che intuisco: la natura del problema, la precisa domanda.
Spesso pure la risposta.
Qualcosa di simile succede in questi due albi, abbastanza diversi, capaci di generare domande cogenti sull’infanzia, sul potere e l’autorità, sugli spazi interiori, senza tuttavia cadere mai nella tentazione di fornire risposte, forti proprio dell’eloquenza del materiale messo in movimento e in virtù del movimento stesso.
In Di qui non si passa un generale generalissimo si proclama l’eroe della storia e mette un soldato di guardia alla linea di attaccatura delle pagine, stabilendo a gran voce che da lì nessuno potrà passare: la pagina di destra è riservata a lui! La guardia blocca diligentemente il passaggio a tutte le persone che non tardano ad arrivare, ognuna spinta da un proposito, un’urgenza personale, un desiderio.
Tra le numerose lamentele e il sempre più chiassoso sconcerto passano ignari due bambini impegnatissimi a non lasciarsi sfuggire la palla con cui stanno giocando. Costretti anche loro a fermarsi, mancano un tiro, e allora è solo una questione di attimi: giusto il tempo che la pallina si fermi al centro della pagina di destra e anche i bambini sono dall’altra parte, seguiti a ruota da tutti gli altri. A nulla servirà l’arrivo del generale e dell’esercito: persino il cavallo si lascerà contagiare dall’anarchia e, disarcionato il proprio stesso padrone, se ne andrà con tutti gli altri, lasciando il sedicente eroe della storia solo e sconsolato a riordinare i resti colorati che, come seconde pelli, rimangono a terra dopo che tutti sono passati.
Tutte quelle cose che non ci stanno più, invece, mette in scena una situazione più intima.
È questa la storia di bambino che si trova ad avere a che fare con misteriose palline arancioni che cominciano inspiegabilmente ad apparirgli in numero sempre crescente. In assenza di una figura di riferimento e di validi suggerimenti, il piccolo tenta in tutti i modi di trovare uno spazio e uno scopo a questi inspiegabili oggetti. Tuttavia né la borsa della palestra del papà, né la cuccia del cane, l’autobus o il carrello della spesa sembrano adatti a contenerle, e al bambino, sovrastato dallo sforzo, non rimarrà che arrendersi alla loro presenza. Sarà dopo questa resa che vedrà qualcuno simile a lui, un altro bambino che, sgattaiolando tra le gambe degli adulti indifferenti, lo condurrà oltre una porta in un giardino dove le palline troveranno il loro posto.
I due dispositivi narrativi presentano certo notevoli differenze:
- Da una parte abbiamo un protagonista adulto, dotato di autorità, che agisce per proprio esclusivo interesse contrapponendosi a una molteplicità di persone libere, ognuna dotata di nome, relazioni amici, e di una direzione ben specifica che le spinge ad affrontare il divieto di non attraversare un dato confine; dall’altra ecco un bambino solitario (o lasciato solo?) alle prese con l’apparizione apparentemente insensata di palline arancioni di cui non è chiaro lo scopo…
- Da una parte i colori squillanti e il tratto nitido dei lampostil danno vita a personaggi dinamici, quasi ritmici, dall’altra una palette di grigi sfumati: delineano con campiture sfumate una serie di ambienti estranei e respingenti in cui l’unico colore concesso è quello delle palline, arancioni e luminose, e il giacchino del bambino, anche questo arancione, come da programma…
- Da una parte l’azione avviene in spazi indefiniti, candidi, e viene interrotta dal bordo della carta, come a suggerire un campo d’azione che supera la struttura del libro per estendersi ben oltre il margine; dall’altra, ecco susseguirsi scenari domestici e urbani di un quotidiano vivere comune che pare ripiegarsi su sé stesso.
- La chiara identificazione del limite e del divieto con l’attribuzione di funzione scenografica alla linea di attaccatura tra le due pagine de Di qui non si passa! si contrappone al confine psicologico che si sostanzia pagina dopo pagina in Tutte quelle cose che non ci stanno più separando gli ambienti esterni dallo spazio interno – attonito e lievemente angosciato - del piccolo protagonista, ma anche gli adulti dall’infanzia.
- Infine, tra i personaggi della folla del primo albo serpeggia un elettrico senso di energia e si aprono variopinti fumetti che sostanziano all’occhio il rumoreggiare delle voci dei molti, rappresentando anche a livello sonoro il crescendo di un attrito tutto esterno tra il generale e la folla. Nelle grigie ambientazioni dove si muove il bambino alle prese con le palline invece, rimbomba in silenzio un conflitto intimo e personale, vissuto in una solitudine sottolineata con puntualità dagli sguardi infastiditi o indifferenti degli adulti.
Tuttavia, la scelta di procedere nella narrazione attraverso il dispositivo dell’accumulo stabilisce una sotterranea comunanza tra questi due albi: entrambi presentano fin dal titolo una negazione, un divieto, una linea di demarcazione, ovvero dispongono un ostacolo contro cui è necessario scontrarsi, e ovviamente entrambi procedono con l’accumulo progressivo di elementi formali proprio contro il margine stabilito dalla negazione; entrambi utilizzano espressivamente la distribuzione del peso dell’immagine nelle pagine, spostandola nel corso della narrazione da sinistra a destra quasi che l’intera struttura fosse un bilanciere e la storia una questione di stabilizzazione di forze fisiche…
Infatti, è fatto grande affidamento sul tempo necessario allo sviluppo della massa critica ed è prevista, alla fine di questo processo, l’apparizione di una soglia funzionale allo scioglimento della tensione creata dall’accumulo stesso.
In questo modo, autori e autrici vanno costruire una efficace metafora delle modalità con cui si sviluppa e sostanzia nella mente un pensiero nuovo, un’idea o una consapevolezza per cui non era previsto uno spazio che tuttavia, da un certo momento in poi, incredibilmente si crea.
L’accumulo funziona ottimamente come dispositivo narrativo: fa nella narrazione quello che tempo e peso fanno alla roccia: strato dopo strato, millennio dopo millennio il depositarsi di materia, riordina i significati, stabilizza i legami, mette in quadratura i conflitti e i rapporti. Così, nasce la lucentezza della malachite, il verde dello smeraldo, la stabilissima trasparenza del diamante.
Ecco allora la critica all’autorità e al rigore, ecco la negazione dello spazio dell’infanzia, ecco un inno alla vitalità dei desideri e all’individualità genuina che nell’infanzia prova a trovare la sua prima legittimazione.
La questione saliente è la fiducia. Saper confidare nel gesto ripetitivo di voltare pagina dopo pagina dopo pagina, rimanendo tuttavia in attesa del mutamento della situazione: che l’equazione si sviluppi, che il processo si compia, che il significato si riveli. Che i materiali – persone, palline pensieri e sentimenti e domande - rivelino attraverso la loro persistenza il proprio messaggio.
Più che logico è inevitabile: l’accumulo è un arrendersi che affida alla natura stessa delle cose la parola, e che accoglie il significato evidenziato dalla ripetizione per restituirlo finalmente intero e visibile alla singolarità. Recuperando l’immagine della diga, è inutile pensare di ostacolare il libero e pulsante fluire di palline, persone, sentimenti e pensieri, stabilire a tavolino che non sia possibile passare: ciò che si accumula è destinato presto o tardi a tracimare, e per tutte le cose che sembrano inizialmente non avere collocazione, per la novità o l’urgenza del loro messaggio, si creerà un nuovo spazio: uno spazio che prima non c’era.
Giorgia
“Di qui non si passa!”, Isabel Minhos Martins, Bernardo Carvalho, Topipittori 2015
“Tutte quelle cose che non ci stanno più” Marta Lonardi, Corraini 2024