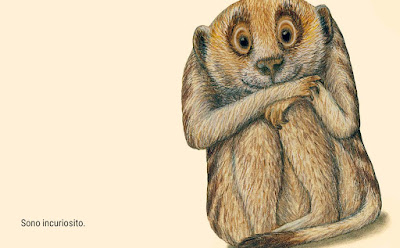TOCCARE IL SOFFITTO CON UN DITO
Oscar e io (e tutti i nostri posti), Maria Parr, Åshild Irgens (trad. Alice Tonzig)
Beisler 2024
NARRATIVA PER MEDI (dai 9 anni)
"In casa abitano due bambini, Oscar e io. Condividiamo la stanza nel seminterrato. Nel letto a castello io dormo sopra e sono il capo. Oscar dorme sotto e crede di essere il vicecapo, ma in realtà sono io a decidere tutto. Decido quando dobbiamo spegnere la luce, e decido che Oscar si deve alzare per farlo. Decido se dobbiamo tenere socchiusa la porta o la finestra. E decido io quando parliamo e quando dormiamo. Vorrei essere io a decidere anche il momento in cui Oscar deve smettere di russare, perché quando attacca sembra un aspirapolvere rotto. Ma l’unico modo per farlo smettere è svegliarlo, e non è che allora ci sia tanto più silenzio, volendo essere gentili."
I due sono a letto e come di consueto discutono. Oscar ha 5 anni e paura dei mostri, dei mostri nell'armadio. Sua sorella, che è di ben tre anni più grande, sa molto bene che i mostri non esistono e quindi lo prende in giro, ma di fatto lo tranquillizza e lui si riaddormenta. Tuttavia quell'anta dell'armadio non perfettamente chiusa genera in lei una piccola paura, che magari cresce: se i mostri non esistono, i ladri invece ci sono, eccome.
Quindi, non resistendo, scende dal letto e va a controllare. Ma un rumore sospetto la mette ancora più in allarme, afferra al volo l'atlante e si nasconde nel buio tra attaccapanni e vestiti. Quando poi l'anta si apre all'improvviso, lei - ed è a questo punto terrore puro - scaglia l'atlante in testa a chi ha di fronte.
Tutto precipita in un baleno: Oscar si sveglia urlando, il papà dal piano di sopra irrompe nella stanza, brandendo la miglior padella di casa, e quel che trova è sua figlia a occhi sgranati che è davanti all'armadio spalancato, sua moglie a terra che si tiene la fronte dolorante, colpita da un pesante atlante e il piccolo Oscar, bianco di paura.
E poi? Mamma si sdraia accanto al piccolo di casa per consolarlo, qualcuno nel letto superiore questa volta farebbe volentieri a cambio con il fratello, il padre riporta in cucina la padella.
E come va a finire? Che nella penombra della camera in quel lettino adesso sono in tre: uno dorme come se nulla fosse successo e le altre due chiacchierano con un fil di voce su cosa sia la paura...
Credo di non sbagliare optando di mettere sotto la lente solo uno degli undici episodi che costituiscono il nuovo e atteso libro di Maria Parr.
Non vorrei togliere a nessuno il gran gusto di leggerlo senza spifferi esterni, vocine che ti dicono qui succede questo, là succede quello... ma soprattutto lo faccio perché in questo, che apre il libro e si intitola L'armadio, ci sono già tutti gli ingredienti per capire che si tratta di un gran bel libro e punto.
Nel sottotitolo c'è il filo rosso che tiene insieme i racconti: sono undici luoghi che costituiscono la mappa, ovvero i diversi scenari dell'infanzia di due bambini, fratello e sorella, con contorno di adulti.
A essere più precisi, si potrebbe dire che è proprio lei, l'infanzia, a essere in questo libro un luogo prima ancora di essere un tempo.
E come spesso accade, i suoi contorni, via via sempre più nitidi, si ricavano attraverso i fatti che si susseguono. Sono principalmente loro a raccontare, in un continuo gioco delle parti tra piccoli e grandi.
Nessuna morale, nessun insegnamento.
Ma andiamo con ordine: prima i bambini e poi gli adulti.
Resto sempre basita quando riconosco, ovvero sento risuonare come suono conosciuto, le infanzie raccontate dai grandi ai bambini.
La Parr non si smentisce neanche stavolta: come già nei precedenti suoi libri, cuce fatti, azioni, accadimenti con pensieri profondi, talvolta profondissimi, che tengono insieme le parti per dare spessore, profondità e senso alle cose. Pensieri che passano veloci, quelli dei suoi bambini, perché è così che pensano i ragazzini: vanno a fondo e poi scartano verso qualche altra cosa... Invece, i pensieri che hanno avuto modo di decantare, sono quelli dei suoi adulti.
La domanda a questo punto si impone: perché solo alcuni adulti, tra cui la Parr, sanno raccontare i bambini meglio di altri?
Forse perché vanno a pescare in quella regione emotiva che non li ha mai abbandonati, ossia raccontano di cose che un adulto e un bambino hanno in condivisione, pur essendo tra loro diversissimi?
Per esempio qui, parlando di paure, è difficile che un grande creda ai mostri, ma la paura di un ladro che violi il nostro rifugio è roba che non ci abbandona mai... E Ida, la sorella "più matura" è lì a dircelo, chiaro e tondo.
E come sono gli adulti di Maria Parr?
Come a spesso accade nei libri del Nord, gli adulti sono gran belle persone, anche nei loro limiti: più volte ci si commuove, e altrettante si piange dalle risate.
La loro bellezza risiede nella grande onestà di presentarsi per quello che si è, nel rispettarsi per quello che si è e nel volersi bene per quello che si è.
Senza mai sottrarsi al loro ruolo di curatori di piccoli in crescita, qui vediamo genitori e zii che si muovono disinvolti tra una gamma molto varia di sentimenti.
Soffrono, ridono, amano, sbagliano, vanno in profondità o galleggiano spensierati davanti a figli e nipoti con una integrità, lealtà, una trasparenza interiore, una consapevolezza di sé così profonda che è davvero difficile non notarla e non apprezzarla.
Faccio anche qui un esempio: madre e figlia chiacchierano sottovoce, prima di separarsi e prendere ognuna - alla pari - la strada verso il proprio sonno. La cosa che è appena accaduta, ossia la paura di un mostro che è diventata la paura di un ladro, nasconde dentro di sé una grande verità che quella "matura" bambina esplicita con estrema chiarezza: "quando smettiamo di avere paura di qualcosa, il cervello scova qualcos'altro di cui avere paura, qualcosa di più pericoloso, e così più diventiamo grandi, peggio è".
Incontrovertibile, ma il modo per andare oltre lo sa solo chi ci è passato attraverso. E non è un caso che ci sia lì una figlia che sulla questione in qualche modo interroga una madre. E così accade che la "grande" racconti alla "piccola".
E come lo fa?
Senza giri di parole, va dritta verso quello che è: nessuna ipocrisia, ma piuttosto affetto, rispetto e tanta vita vera...
E cosa le dice?
Questo: «Quando diventiamo grandi, dobbiamo spesso prenderci cura di qualcuno. E allora va meglio.» «Ah, sì?» «Sì. Se ci si deve prendere cura di qualcuno più piccolo di noi, qualcuno che è più spaventato, non rimane così tanto spazio per le nostre paure. Per questo quando ero piccola volevo un fratellino o una sorellina», ha aggiunto. E poi ha raccontato che zio Øyvind, suo fratello maggiore, la sera doveva sempre accompagnarla su per le scale della mansarda, perché lei credeva che dietro la carta da parati abitasse un fantasma che quando era buio veniva fuori attraverso una fessura. Io mi sono messa a ridere.«Ma adesso devo prendermi cura di te e Oscar, così ho il coraggio di salire le scale da sola. Senza problemi.»
Ecco.
Moltiplicate tanta bellezza per enne volte e otterrete questo libro magnifico!
Carla